l’Esortazione apostolica di Papa Leone XIV Dilexi te, come afferma lo stesso Pontefice, è il seguito dell’Esortazione apostolica – l’ultima – di Papa Francesco Dilexit nos, anzi “stava preparando, negli ultimi mesi della sua vita, un’Esortazione apostolica sulla cura della Chiesa per i poveri e con i poveri… immaginando che Cristo si rivolga ad ognuno di loro dicendo: Hai poca forza, poco potere, ma <<io ti ho amato>> (Ap 3,9)” (DT 3). La poca attenzione suscitata d Dilexit nos, dato che non parlava di “temi scottanti” quali ecologia, giustizia sociale, pace ecc. ma toccava il punto fondamentale, ossia il Cuore Divino-Umano di Cristo in cui risiede la fonte e il modello di tutta l’opera della Chiesa, è compensata dall’attenzione di cui invece gode Dilexi te, specialmente da parte di coloro che si aspettavano un messaggio di “rottura” dell’attuale Pontefice rispetto al suo predecessore. Naturalmente un’attesa “ingenua”: nessun Pontefice “rompe” con i suoi predecessori ma non fa altro che sviluppare quello che appartiene alla Chiesa, al suo messaggio fondamentale, che ogni pontefice approfondisce insieme a tutta la Chiesa per offrire quell’aspetto particolare del Vangelo di cui i tempi presenti hanno bisogno per intendere tutto intero il messaggio del Salvatore.
Vogliamo richiamare alcuni punti del documento che potranno essere utili alla riflessione personale e comunitaria.
Dilexi te non si pone semplicemente come un documento “pastorale” che, comunque, avrebbe sempre un fondamento dottrinale, ma come un documento che appartiene pienamente al Magistero ordinario della Chiesa in quanto chiarisce il fondamento ultimo dell’attenzione che la Chiesa presta ai poveri e, perciò, alla sua opzione preferenziale per essi. La povertà in genere è presentata come una categoria teologica e i poveri come segno sacramentale.
La povertà è categoria teologica perché appartiene al mistero dell’Incarnazione del Verbo, il quale “<<svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo>> (Fil 2,7)… Si tratta di una povertà radicale, fondata sulla sua missione di rivelare il vero volto dell’amore divino (cfr Gv 1,18; 1Gv 4,9). Pertanto, con una delle sue mirabili sintesi, San Paolo può affermare: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» ( 2Cor 8,9)>> (DT 18).
La vita del Signore trascorse, di fatto nella povertà: << Vi sono alcuni indizi a proposito della condizione sociale di Gesù. Anzitutto, egli svolge il mestiere di artigiano o carpentiere, téktōn (cfr Mc 6,3). Si tratta di una categoria di persone che vivono con il loro lavoro manuale. Non essendo possessori di terra, venivano considerati inferiori rispetto ai contadini. Quando il piccolo Gesù viene presentato al Tempio da Giuseppe e Maria, i suoi genitori offrirono una coppia di tortore o di colombi (cfr Lc 2,22-24), che secondo le prescrizioni del Libro del Levitico (cfr 12,8) era l’offerta dei poveri.>> (DT 20).
Nella povertà del Signore si realizza quella vicinanza di Dio al suo popolo, e a tutta l’umanità, già manifestata nell’ Antico Testamento. “non indica mai un esclusivismo o una discriminazione verso altri gruppi, che in Dio sarebbero impossibili; essa intende sottolineare l’agire di Dio che si muove a compassione verso la povertà e la debolezza dell’umanità intera e che, volendo inaugurare un Regno di giustizia, di fraternità e di solidarietà, ha particolarmente a cuore coloro che sono discriminati e oppressi, chiedendo anche a noi, alla sua Chiesa, una decisa e radicale scelta di campo a favore dei più deboli” (DT 16). L’immersione di Gesù nella nostra miseria, nella nostra povertà essenziale di creature che tutto ricevono dalla misericordia di Dio, diventa così un vero principio teologico per comprendere appieno il contenuto della Rivelazione divina e un richiamo per tutti, ricchi o poveri.
Da questo deriva quello che possiamo chiamare il significato sacramentale dei poveri. Gesù si identifica con essi – con tutti – tanto che il giudizio sul bene o sul male che avremo fatto verterà in particolare sulla misericordia usata verso i poveri, perciò l’amore a Dio non può dirsi autentico senza l’amore verso i poveri. Vi è così un’analogia chiarissima, che Papa Leone si limita a mettere in luce quando afferma: “Questa condivisione dei beni nasce dunque dalla carità teologale e ha come fine ultimo l’amore di Cristo. Per Agostino, il povero non è solo una persona da aiutare, ma la presenza sacramentale del Signore” (DT 44).
Parlando poi degli Ordini religiosi, espressione dell’essenza della vita della Chiesa e dei cristiani, sottolinea come essi, non soltanto quelli specificamente dedicati all’assistenza dei poveri, ma anche gli ordini monastici, esemplificati in quelli di san Basilio e san Benedetto, si dedicassero all’ospitalità e alla cura dei poveri. Parlando poi dei Trinitari e dei Mercedari, che si occupavano in particolare della liberazione degli schiavi cristiani, fino ad offrire se stessi al posto di quelli, afferma che “i religiosi non vedevano il riscatto come un’azione politica o economica, ma come un atto quasi liturgico, l’offerta sacramentale di sé stessi” (DT 61).
Lo spirito che ha guidato – e guida ancora – questi Ordini religiosi, si esprime oggi nell’opera della Chiesa e dei singoli cristiani che combattono le ingiustizie, le nuove oppressioni a livello globale. E qui è bene ricordare come nel catechismo uno dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio è proprio l’oppressione dei poveri. Questo è bene che lo tengano presente quei politici che dicendosi “cristiani” e “cattolici” pretendono di difendere le “tradizioni cristiane” appoggiando iniziative quanto meno discutibili, specialmente nelle loro modalità, di “controllo” delle migrazioni.
Tuttavia la Chiesa non è una società filantropica. La povertà è per tutti i credenti un vero programma di vita, una “regola” generale che per i ricchi – singoli e società – diventa coscienza che i beni materiali, destinati al bene di tutti, vengano usati da chi li possiede facendoli fruttare per migliorare le condizioni globali della società, specialmente dei più poveri, mentre rimane fermo il principio che chi li usa direttamente lo faccia con sobrietà e distacco affettivo per non correre il rischio di trasformarli in un idolo micidiale per il destino eterno, come insegna Gesù nella parabola del ricco indifferente verso il povero Lazzaro (cfr Lc 16,19-31).
A questi principi validi per tutti i cristiani, anzi per tutti gli uomini, richiama la vocazione particolare dei religiosi in cui la professione religiosa è una vera profezia della povertà quale completa immersione nel mistero di Cristo. E qui il Santo Padre presenta san Francesco: “La sua vita fu una continua spogliazione: dal palazzo al lebbroso, dall’eloquenza al silenzio, dal possesso al dono totale. Francesco non ha fondato una realtà di servizio sociale, ma una fraternità evangelica. Nei poveri ha visto fratelli e vive immagini del Signore. La sua missione era di stare con loro, per una solidarietà che superava le distanze, per un amore compassionevole. La sua povertà era relazionale: lo portava a farsi prossimo, uguale, anzi, minore. La sua santità germogliava dalla convinzione che si può ricevere veramente Cristo solo donandosi generosamente ai fratelli” (DT 64). Farsi prossimo dei poveri, vicino accettandoli per quello che sono, spesso vale molto più del soccorso materiale, anzi quest’ultimo perderebbe tutto se fosse mera “burocrazia caritativa” che ignora il contatto umano.

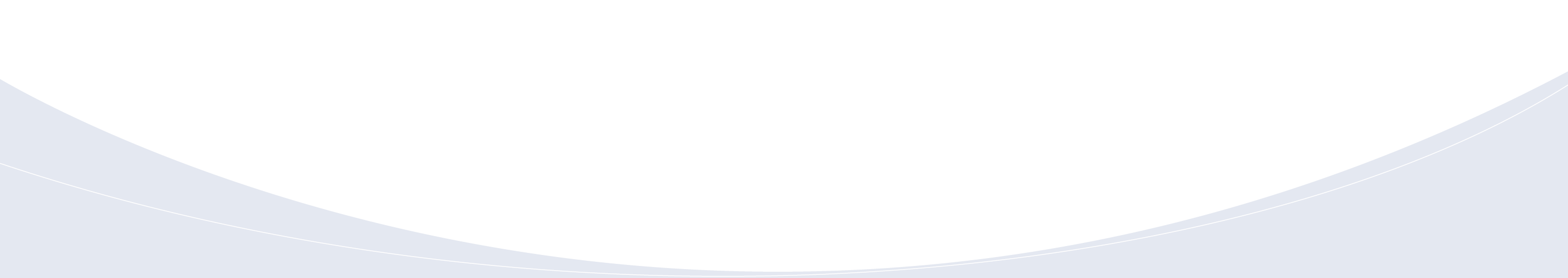



0 commenti