Il 2 agosto, mentre la Chiesa celebra il Perdono di Assisi, a Frigento, in Irpinia, si ricorda un altro inizio: l’inizio di un cammino spirituale e comunitario che ha dato origine, tra luci e ombre, all’Istituto dei Frati Francescani dell’Immacolata. Era il 1970 quando, in una cornice semieremitica e ancora incerta, un piccolo gruppo di frati minori conventuali cominciava a interrogarsi sul senso della vita religiosa dopo il Vaticano II, avvertendo — non senza eccessi — la fatica di un aggiornamento ecclesiale percepito come disorientante.
Quel nucleo originario cercava nel silenzio, nella povertà e in una certa austerità un nuovo inizio. Tuttavia, il rischio evidente era quello del “ripristino nostalgico”: un tentativo, più reattivo che profetico, di restaurare elementi esteriori del francescanesimo pre-conciliare. La provincia religiosa napoletana dei Conventuali, permise l’impianto di un noviziato prima e di uno studentato poi, segno che l’esperienza stava suscitando un certo fermento. Già nel 1978 si aprì una missione nelle Filippine, guidata da P. Gabriele M. Pellettieri, allora compagno fedele dell’iniziatore P. Stefano M. Manelli — e che sarà nel tempo coinvolto di sponda in alcune criticità che sarebbero emerse nell’Istituto.
L’epopea dell’Immacolata: missione, media e vocazioni
Già dai primi anni 70 nacque una tipografia, poi una casa editrice, nel 1978 una radio e infine, nel 1988, anche una televisione cattolica. Al 1989 risale anche l’arrivo della prima comunità di Suore Francescane dell’Immacolata, provenienti dalle Filippine. Il carisma mariano francescano cominciava a concretizzarsi in forme nuove, con frutti visibili: vocazioni in crescita, slancio missionario, presenza pubblica.
Ma nel 1990 tutto cambiò. P. Stefano M. Manelli, iniziatore dell’esperienza, rifiutò la centralizzazione della formazione prevista dall’Ordine conventuale, preferendo l’autonomia. Iniziò così la separazione canonica dall’Ordine e la fondazione dei Frati Francescani dell’Immacolata, con approvazione diocesana nel 1990 e pontificia nel 1998.
Tra idealismo, ambiguità e crisi d’identità
I primi anni dei Francescani dell’Immacolata furono travolgenti: missioni in Africa, Asia, America Latina, vocazioni numerose, un entusiasmo carismatico reale. Ma si cominciarono anche a intravedere le fragilità: una struttura identitaria incerta, oscillante tra clarianesimo monastico, pratiche dei cappuccini prima del Concilio, donchichiottismo teologico e polemico e crescente autoreferenzialità dottrinale e formativa.
Con l’uscita del Motu Proprio Summorum Pontificum di Benedetto XVI (2007), l’Istituto — per esplicita volontà di P. Stefano M. Manelli, e non della maggioranza dei membri — adottò la forma straordinaria del rito romano come esclusiva in molte comunità, a partire dalle case di formazione. Non fu una scelta sinodale né frutto di un discernimento comunitario, ma una direttiva imposta dall’alto, legata a un crescente irrigidimento liturgico e dottrinale. Fu un cambio di rotta radicale, percepito come identitario-ideologico più che pastorale e spirituale.
Dal 2013, con il commissariamento disposto dalla Santa Sede (11 luglio), iniziò il tempo della crisi e della purificazione. La figura dell’iniziatore, ritenuto ancora moralmente autorevole da molti, mostrò ulteriori criticità di governo, specie per l’irrigidimento nelle relazioni interne e la gestione centralizzata delle decisioni. Altre preoccupazioni sorsero per la gestione patrimoniale affidata a enti civili collegati all’opera, con conseguente perdita di controllo diretto da parte dell’Istituto, e per l’intento di costituire un gruppo parallelo non allineato alla Chiesa.
Oggi: dal disorientamento alla rinascita
Il commissariamento ha portato l’Istituto a un bivio: perdere tutto o riscoprire il nucleo fondativo autentico. Non bastava tornare alle origini del 1970: bisognava liberarsi da sovrastrutture personali, da ideologie deviazioniste, da nostalgie “controriformiste“. Bisognava ritrovare l’essenziale kolbiano: la totale appartenenza all’Immacolata, vissuta nella minorità, nella missione, nella fedeltà alla Chiesa.
Nel 2022, terminata la fase di accompagnamento ecclesiale, l’Istituto ha voltato pagina. Ha rinunciato alla retrotopia del fondatore storico, si è affrancato da ogni devozione malata all’uomo, ha iniziato a riformulare la propria identità nella fedeltà a san Francesco, san Massimiliano Kolbe e al Concilio Vaticano II, senza più esitazioni.
Oggi i Frati Francescani dell’Immacolata si muovono in questa direzione: formazione solida, fedeltà liturgica, apertura alla missione, spiritualità mariana non autoreferenziale, media come strumenti per servire, non per costruire potere e propaganda.
Frigento oggi: una Casa Mariana, non un museo
A 55 anni da quel 2 agosto 1970, Frigento non è un santuario della nostalgia, ma una casa viva, Mariana e francescana, sede di noviziato e Delegazione europea, dove non si adora il fondatore, ma si adora Cristo con Maria, nella Chiesa, per il mondo.
E se le ferite del passato sono ancora aperte in alcuni cuori, il futuro si apre limpido a chi sa discernere i segni dei tempi, correggere i propri errori e camminare nella verità.
Il tempo del culto dell’iniziatore è finito. È il tempo del ritorno all’Immacolata, vera e unica fondatrice spirituale dell’Istituto.

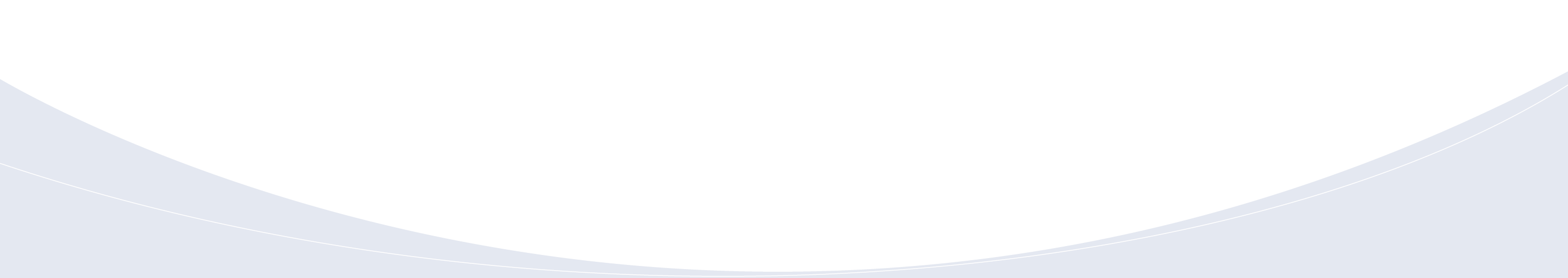




0 commenti