Quando si cerca di comprendere quali siano le radici della spiritualità francescana, il pensiero corre subito al Vangelo vissuto sine glossa, alla radicalità evangelica di Francesco d’Assisi e alla grande sintesi teologica di autori come Bonaventura e Duns Scoto. Tuttavia, accanto a queste fonti proprie dell’esperienza minoritica, non si può trascurare l’influsso profondo di Sant’Agostino, che pur non essendo mai stato assunto come “dottore” dell’Ordine, ha lasciato un’impronta duratura nella teologia e nella spiritualità francescana.
Francesco non cita mai direttamente Agostino, ma la consonanza spirituale è evidente. L’invito del vescovo d’Ippona a rientrare in se stessi per scoprire Dio più intimo a noi di noi stessi trova eco nel richiamo francescano a “dimorare nello spirito del Signore e nella sua santa operazione”. Così come il suo accento sulla povertà di Cristo e della Chiesa, pur espresso in contesti diversi, anticipa la radicalità evangelica di Francesco e dei suoi primi compagni.
La cornice culturale medievale spiega questa sintonia. Quando i primi maestri francescani si formano nelle scuole teologiche, soprattutto a Parigi, Agostino era ancora l’autore di riferimento, letto attraverso i Sententiarum libri di Pietro Lombardo. In quell’ambiente i frati respirano un’aria decisamente platonico-agostiniana: la conoscenza non è solo il frutto dell’esperienza sensibile, come insegnava Aristotele, ma nasce dall’illuminazione divina che orienta l’intelletto; le idee sono viste come esemplari eterni in Dio; l’itinerario dell’anima verso il Creatore è concepito come un’ascesa dai segni visibili all’invisibile.
In questo contesto si comprende bene come i francescani siano stati, nelle origini, molto più platonici che aristotelici. Alessandro di Hales, il primo grande maestro dell’Ordine, rappresenta l’erede diretto dell’agostinismo scolastico, soprattutto nelle riflessioni sulla grazia e sul peccato originale. San Bonaventura, vertice della prima generazione, porta questa eredità a maturazione: la sua dottrina dell’illuminazione, la concezione della storia come itinerario verso Dio e la centralità dell’amore come forma della conoscenza rivelano chiaramente le radici platoniche, rilette però con un forte accento cristocentrico e affettivo, tipicamente francescano.
Con Giovanni Duns Scoto la situazione cambia. La sua teologia mostra una maggiore attenzione alle categorie aristoteliche, soprattutto nella logica e nella metafisica. Tuttavia, Scoto non diventa mai un aristotelico puro come Tommaso d’Aquino: resta infatti fedele al primato della volontà, all’idea dell’amore come via regale verso Dio e alla convinzione che Cristo sia al centro della creazione indipendentemente dal peccato. In questo senso, il Doctor Subtilis rappresenta un superamento creativo: utilizza gli strumenti di Aristotele, ma mantiene l’anima agostiniana e francescana del primato della carità e della grazia.
Il confronto con i domenicani chiarisce ancora meglio questa distinzione. Se l’Ordine fondato da Domenico ha trovato in Aristotele il suo punto di riferimento privilegiato, i francescani hanno custodito la tradizione agostiniana, lasciandosi guidare più dall’interiorità che dall’analisi razionale, più dal primato dell’amore che da quello dell’intelletto. Non per nulla, Bonaventura non si stanca di ripetere che “non è la conoscenza che salva, ma l’amore”.
Se si volesse condensare in due parole l’eredità di Agostino nella spiritualità francescana, esse sarebbero interiorità e carità. L’interiorità, intesa come luogo dell’incontro personale con Dio, diventa vita di orazione e di contemplazione silenziosa, quella preghiera che Francesco amava vivere nelle grotte e negli eremi. La carità, definita da Agostino “forma di tutte le virtù”, trova nel Poverello la sua traduzione concreta in fraternità universale, servizio agli ultimi e amore appassionato per il Crocifisso.
Ecco perché si può dire che la sapienza francescana nasce da una matrice platonico-agostiniana, che poi si sviluppa con originalità, intrecciando interiorità e missione, contemplazione e fraternità, amore di Dio e amore delle creature. Se Tommaso d’Aquino e i domenicani hanno dato alla Chiesa il volto di un aristotelismo cristiano, Bonaventura, Scoto e la tradizione minoritica hanno custodito e rinnovato l’anima agostiniana del Vangelo. In definitiva, nella storia dell’Ordine francescano la filosofia non è mai fine a se stessa: Platone, Aristotele e Agostino sono strumenti, ma il cuore rimane quello di Francesco, che non cercava sistemi, ma un Amore da vivere.

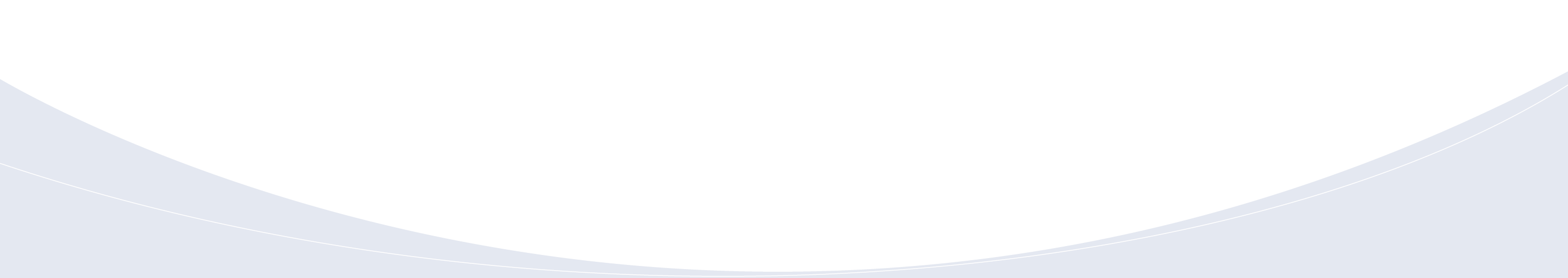




0 commenti