La figura di Maria Addolorata occupa un posto centrale nella tradizione cristiana: la liturgia, la spiritualità popolare e la riflessione teologica hanno visto in lei la Madre che soffre con il Figlio e che, nella fede, partecipa in modo singolare al mistero della Redenzione. Tuttavia, il titolo di “Corredentrice”, che intende esprimere questa cooperazione, è stato negli ultimi decenni oggetto di un dibattito acceso e non sempre sereno. Invece di arricchire la mariologia, la disputa ha spesso generato polarizzazioni, talvolta poco feconde per il dialogo ecumenico e la vita ecclesiale.
Eppure, il mistero di Maria “associata” alla Redenzione affonda le sue radici nei Padri della Chiesa, si sviluppa nella pietà medievale, trova una sintesi nel pensiero francescano e rimane oggi un campo di discernimento teologico e pastorale.
Fondamenti patristici: la nuova Eva
I Padri della Chiesa hanno posto le basi di ciò che la teologia successiva chiamerà “corredenzione”.
- Sant’Ireneo di Lione vede in Maria la “nuova Eva”: “Sicut illa [Eva] ligavit per incredulitatem, sic ista [Maria] solvit per fidem”, affermando che Maria “divenne causa di salvezza per se stessa e per tutto il genere umano”¹.
- Sant’Efrem il Siro la chiama “avvocata del genere umano” e celebra in versi la sua mediazione materna².
- Sant’Ambrogio di Milano, commentando la croce, scrive: *“Stabat iuxta crucem mater, non sine consilio Dei”*³, sottolineando che la sua presenza non fu casuale ma parte integrante del disegno divino.
Queste testimonianze mostrano che la cooperazione di Maria alla salvezza è un dato originario della fede cristiana, anche se non ancora espresso con la terminologia successiva.
La Madonna Addolorata: liturgia e spiritualità
Il titolo di Mater Dolorosa ha conosciuto una straordinaria diffusione nella pietà medievale e moderna. Lo Stabat Materattribuito a Jacopone da Todi, le confraternite dei Servi di Maria e la devozione ai “Sette Dolori” hanno contribuito a fissare nella coscienza ecclesiale l’immagine della Madre compassionevole.
La liturgia colloca la memoria della Madonna Addolorata subito dopo l’Esaltazione della Croce (15 settembre), quasi a sottolineare che il mistero della sofferenza del Figlio non può essere contemplato senza la presenza della Madre. La Mater Dolorosa diventa così icona della Chiesa che soffre con Cristo e che accompagna i fedeli nel cammino della speranza.
La categoria di “Corredentrice”: genesi e tensioni
A partire dal tardo Medioevo si diffondono i titoli di socia Christi, redemptrix e poi corredemptrix, per indicare la cooperazione singolare di Maria alla Redenzione. Nel XX secolo il cardinale Mercier ne chiese la definizione dogmatica; Giovanni Paolo II ne fece uso in contesti pastorali⁴.
Eppure, anziché leggere questa prudenza come un invito al discernimento, il dibattito si è talora trasformato in terreno di scontro ideologico: da un lato i fautori del “quinto dogma mariano”, dall’altro i timorosi di ogni sviluppo mariologico. La conseguenza è stata una mariologia difensiva, incapace di generare un discorso vivo e propositivo, e di mostrare la bellezza della cooperazione mariana come icona ecclesiale.
Il Concilio Vaticano II, in Lumen Gentium, parla di Maria “associata all’opera del Salvatore”⁵, evitando però il termine. Papa Benedetto XVI e Papa Francesco hanno espresso cautela, privilegiando titoli già consolidati, come “Madre della Chiesa”. Francesco, in una catechesi del 2021, affermò che Maria “non è corredentrice” in senso tecnico, ma che è Madre che accompagna e mai ruba nulla al Figlio⁶.
Negli ultimi anni, il dibattito sul “quinto dogma” si è spesso irrigidito in contrapposizioni, producendo più calore che luce. Invece di servire la mariologia, l’ha talvolta intrappolata in schemi ideologici.
Il problema, tuttavia, non è solo terminologico ma metodologico. La disputa attorno al titolo ha spesso generato un clima di contrapposizione: chi lo promuove come definizione dogmatica definitiva, e chi lo rifiuta con timore quasi panico. In mezzo, il rischio che il senso autentico della cooperazione mariana si perda in un linguaggio polarizzato.
La prospettiva francescana: Duns Scoto e Kolbe
Il contributo della scuola francescana è fondamentale. Giovanni Duns Scoto, applicando la massima di Guglielmo de Ware, potuit, decuit, ergo fecit, aveva già elaborato una visione che valorizza l’elezione singolare di Maria: Immacolata perché predestinata a essere la più perfetta cooperatrice di Cristo⁷.
San Massimiliano Kolbe, figlio del carisma francescano, radicalizza questa intuizione nella sua teologia dell’Immacolata. Egli vede Maria come “icona” della cooperazione perfetta con Cristo e “sposa dello Spirito Santo”, totalmente orientata alla Redenzione delle anime⁸. Pur non usando il titolo di Corredentrice, Kolbe ne sviluppa l’intuizione profonda: Maria partecipa in modo unico all’opera salvifica senza nulla sottrarre al primato di Cristo.
Una via di discernimento sereno
Alla luce di queste prospettive, appare chiaro che:
- La cooperazione mariana è radicata nella Scrittura e nella Tradizione, già presente nei Padri.
- Il titolo di “Corredentrice” può esprimere questa verità, ma non deve oscurare l’unica mediazione di Cristo.
- La mariologia deve evitare polarizzazioni sterili e ritrovare un linguaggio che custodisca la ricchezza del mistero senza cadere in slogan ideologici.
Maria Addolorata, ai piedi della croce, è l’immagine che riunisce le dimensioni bibliche, patristiche, liturgiche e teologiche: non una rivale del Redentore, ma la Madre che soffre con lui e con noi, immagine della Chiesa e segno di speranza.
Negli ultimi decenni, il dibattito sul titolo di “Corredentrice” non sempre ha giovato alla mariologia, rischiando di ridurla a terreno di contrapposizione. Eppure, tornando alle radici patristiche e riscoprendo la forza della pietà liturgica e popolare, possiamo ritrovare serenità e profondità.
Maria Addolorata e Corredentrice non è un vessillo da opporre, ma un mistero da contemplare: una cooperazione unica, subordinata, ecclesiale, che ci ricorda come la Chiesa tutta sia chiamata a partecipare, nella fede e nell’amore, all’opera del Redentore.
Forse la via d’uscita non è cercare nuovi dogmi, ma ripartire da un linguaggio condiviso e biblicamente fondato. Maria Addolorata, unita al Figlio nella Passione, è immagine della Chiesa che soffre, spera e intercede. La categoria di “corredenzione”, se compresa in senso analogico e non competitivo con Cristo, resta valida; ma non va brandita come vessillo di parte.
Il compito della mariologia è custodire la verità di fede, ma anche renderla intelligibile e feconda per il nostro tempo. In un mondo segnato da nuove croci – guerre, migrazioni, solitudini – la Madre Addolorata è compagna universale, non bandiera di partito teologico.
La vera sfida è ritrovare uno stile di riflessione sereno, capace di valorizzare ciò che la Scrittura, la Tradizione e il Magistero affermano con chiarezza: Maria è la Madre associata alla Redenzione, immagine della Chiesa, segno di speranza per ogni credente.
La mariologia, per servire davvero la Chiesa, deve evitare le polarizzazioni e ritrovare il coraggio di mostrare Maria come Addolorata e Madre, non come oggetto di contesa. Solo così la riflessione mariologica tornerà a svolgere la sua funzione propria: introdurre il popolo di Dio al cuore del mistero cristiano, dove Cristo è l’unico Redentore e Maria la madre che, con lui e in lui, continua a generare alla vita della grazia.
Note
- Ireneo di Lione, Adversus haereses III,22,4, in Sources Chrétiennes 211, Paris: Cerf, 1974.
- Efrem il Siro, Hymni de Nativitate 11, in Sancti Ephraem Syri Hymni et Sermones, ed. E. Beck, CSCO 186, Louvain: Peeters, 1958.
- Ambrogio, Expositio Evangelii secundum Lucam X,132, in CSEL 32/4, Vienna: Hoelder, 1902.
- Giovanni Paolo II, Udienza generale del 8 settembre 1982, in Insegnamenti V/3 (1982), 404-406.
- Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 58 e 61.
- Francesco, Catechesi, 24 marzo 2021, in L’Osservatore Romano, 25 marzo 2021, 7.
- Giovanni Duns Scoto, Ordinatio III, d. 3, q. 1, ed. Vaticana, Città del Vaticano, 1954.
- Massimiliano M. Kolbe, Scritti, Roma: Città Nuova, 1997, n. 1318.

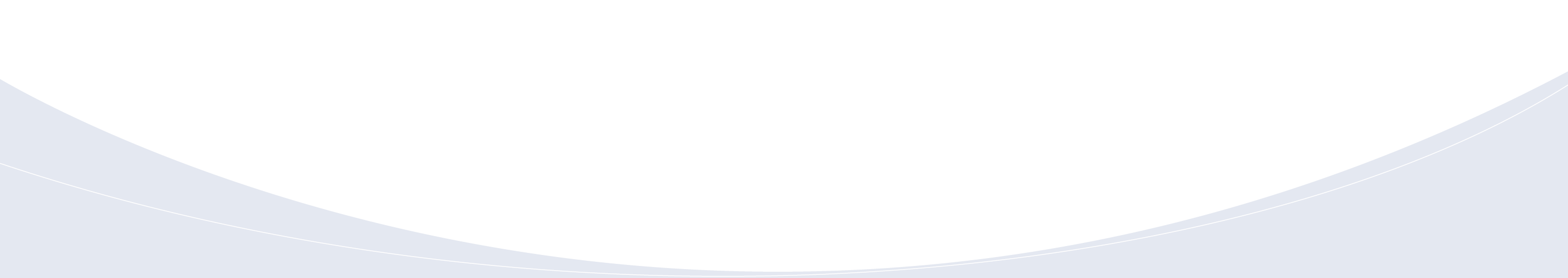




0 commenti